La Carta etica: più necessaria che mai
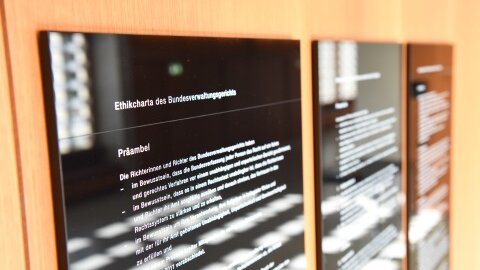
Al momento la giustizia è oggetto di critiche da parte del Parlamento, dei media, della società civile e persino, recentemente, delle cattedre di diritto. C’è chi ci rimprovera di non impegnarci abbastanza per raggiungere i nostri obiettivi, chi di non funzionare in modo efficace, chi di giudicare secondo criteri politici piuttosto che giuridici. Sono critiche evidentemente gravi, che meritano di essere valutate con la dovuta serietà. Alcuni sostengono che, di fronte all’urgenza e alla necessità, occorrerebbe modificare la nostra organizzazione e il nostro sistema di funzionamento, altri addirittura che dovremmo rivedere i principi sanciti nella nostra Carta etica.
La Carta etica come orientamento di massima
Far questo significherebbe dimenticare chi siamo e perché ci siamo prefissi questi principi. Essi formulano regole che disciplinino la vita all'interno del nostro Tribunale e che ci permettano di svolgere al meglio il nostro compito fondamentale: pronunciare decisioni imparziali e di buona qualità in un clima di lavoro il più armonioso possibile. Se ci siamo dati queste regole è perché eravamo consapevoli del fatto che siamo chiamati a fornire un servizio pubblico. Enunciarle è dunque esprimere l’idea che non siamo qualcosa di fine a se stesso.
«La Carta etica ricorda i principi fondamentali che sottendono il nostro funzionamento. Esprime i principi che devono guidarci per superare tutte le difficoltà, anche quelle che esulano dalle cause in sé.»
Gérald Bovier
Vero è che queste regole non sono facili da applicare nella vita quotidiana. Implicano un certo impegno. Noi, insieme a tutti coloro che compongono questo Tribunale, siamo lo specchio della società globale, in tutta la sua poliedricità, la sua ricchezza, ma anche nelle sue molte contraddizioni. Una società divisa, a volte addirittura lacerata quando si tratta di affrontare i temi sociali del nostro tempo. Occorre quindi riflettere sul modo in cui si lavora insieme. Ed è qui che le regole di condotta, in quanto orientamento di massima, si rivelano utili. Anche se generali e non vincolanti, anche se suscitano domande e interrogativi senza fornirci una risposta definitiva. Fino a dove si spinge l’indipendenza? Si può essere imparziali quando ciascuno di noi ha alle spalle la sua cultura, la sua storia personale, i suoi valori? Dove comincia il pregiudizio? Dove sono i limiti del rispetto dell’altro quando un giudice deve essere se stesso e al contempo dimostrare la propria indipendenza?
Trovare un equilibrio
Eppure, un modus vivendi dobbiamo trovarlo. È una questione di equilibrio. Come sempre quando si vive e si lavora insieme. Il mondo che ci circonda è diventato ipercritico, ma noi viviamo in questo mondo, al centro delle sue realtà e dei suoi sviluppi, e non possiamo sottrarci a questa circostanza. Abbiamo un mandato costituzionale da adempiere, il cittadino si fida di noi. E noi dobbiamo essere degni di questa fiducia, malgrado la polarizzazione della società e le aspettative contraddittorie che essa genera.
La Carta etica ricorda i principi fondamentali che sottendono il nostro funzionamento. Esprime i principi che devono guidarci per superare tutte le difficoltà, anche quelle che esulano dalle cause in sé. I principi che detta devono aiutarci a concentrarci sull’essenziale, a giudicare con il debito distacco. Nel contesto attuale, la Carta etica è dunque più necessaria che mai. Ad essa dobbiamo ispirarci per affermare la nostra indipendenza in quanto istituzione, in quanto rappresentanti di un terzo potere che sa elevarsi al di sopra delle parti. Dobbiamo dunque andare fieri di questo testo e del ruolo pionieristico che abbiamo svolto nell’adottarlo!
Ulteriori link
Altri articoli del blog
Più sogni in una stessa culla
Cullare più sogni alla volta si può solo laddove c’è dialogo e rispetto reciproco. Basta avere indipendenza di spirito, modestia e autocritica: così scriveva il giudice Gérald Bovier nel 2021 a proposito della Carta etica del Tribunale amministrativo federale.
La collaborazione migliora la qualità delle sentenze
Secondo Marianne Ryter, presidente del TAF, la qualità di una sentenza dipende da diversi fattori. Uno di questi è la collaborazione in seno al collegio giudicante.
